Francesi, fiorentini e catalani
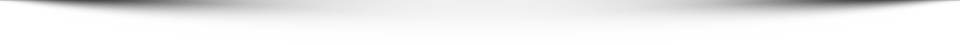
Federico II morì a cinquantasei anni, forse di dissenteria, in un oscuro castelletto nei pressi di Foggia chiamato Fiorentino. Nelle cronache si legge che gli era stato predetto in vita che sarebbe morto sub flore: sotto un fiore. Per questo non aveva mai voluto visitare Florentia, cioè Firenze, ma non gli servì.
Gli succedette sul trono il figlio Manfredi, nato a Venosa dalla sua relazione con Bianca Lancia. Il nuovo re sostenne con tutte le forze l’autonomia del Regno e la laicità dello stato contro le ingerenze sempre più forti del papa. Erano gli anni degli scontri tra Guelfi e Ghibellini: Manfredi fu il massimo rappresentante e il punto di riferimento di quest’ultima fazione e combatté aspramente per la causa, anche fuori dai confini meridionali come nella celebre battaglia di Montaperti, vinta contro Firenze insieme ai senesi. Più volte Dante, vissuto pochi anni dopo quegli eventi, narra nella Divina Commedia delle gesta di Manfredi, rappresentante del potere universale dell’impero.
L’avventura della famiglia Hohenstaufen nel Sud ha termine con la definitiva vittoria di Charles d’Anjoux, fratello del re di Francia, sul nipote di Federico II: Corradino di Svevia. Ingannato da uno stratagemma ideato da Alardo di Valery, che fece travestire un aiutante di campo con le insegne del re, il giovane svevo fu pesantemente sconfitto a Tagliacozzo. Riuscì a fuggire, ma fu poi tradito da Giovanni Frangipane che lo ospitava a Terracina e lo consegnò a re Carlo, il quale lo fece decapitare sulla piazza del Mercato a Napoli, con il consenso del papa.
Si narra che prima dell’esecuzione il ragazzo abbia lanciato il suo guanto sulla folla. Esso fu raccolto da uno sconosciuto mentre un’aquila sorvolava il cielo di Napoli, per poi allontanarsi verso nord. Quello stesso guanto si dice che apparve poi indossato dalla mano che suonò le campane di Palermo, per chiamare a raccolta i siciliani nella rivolta dei Vespri contro gli angioini.
Quest’insurrezione contro i francesi e a favore degli svevi fu perfino elevata al rango di simbolo patriottico italiano durante il Risorgimento, entrando addirittura in un verso dell’inno di Mameli: Il suon d’ogni squilla i Vespri suonò. La triste vicenda di Corradino è poi raccontata nell’omonima poesia dell’800 di Aleardo Aleardi, anch’essa una metafora patriottica all’interno del movimento risorgimentale italiano.
Insediatosi al potere, Re Carlo fece notevolmente ampliare il castello di Melfi, dotandolo della cinta più esterna di torri e ingrandendo gli appartamenti regi, sotto la guida dell’architetto Pierre d’Agincourt. In realtà, però, il centro reale del potere si spostò ben presto a Napoli, dove Carlo fece trasferire il grande archivio regio.
Persa la sua centralità, Melfi per la prima volta fu concessa in feudo a Sancia, moglie di Roberto d’Angiò, e poi al mercante toscano Niccolò Acciaioli. All’epoca i fiorentini erano fortemente presenti in città, come in tutto il Sud: basti citare la lunga permanenza di Giovanni Boccaccio a Napoli. Ciò era dovuto anche ai forti legami tra Firenze e il Regno di Napoli, che dal 1313 erano entrambi sotto lo scettro di Roberto d’Angiò.
A Melfi risiedettero tra gli altri i Portinari, la famiglia della Beatrice di Dante. Uno di essi è sepolto nella chiesa medievale oggi dedicata a Sant’Antonio di Padova, attigua al convento francescano. Si tratta di uno dei conventi più antichi d’Italia, probabilmente risalente nel primo impianto alla stessa epoca in cui visse il santo di Assisi.
Nel frattempo stava per giungere al sud un nuovo dominatore, stavolta dalla lontana Catalogna. Nostalgici degli svevi, i siciliani si erano ribellati agli Angiò con la guerra del Vespro e si erano affidati al catalano Pietro d’Aragona, che era il genero di re Manfredi. Gli aragonesi non possedevano estesi territori sulla terraferma, ma preferivano governare una miriade di città costiere lungo tutto il Mediterraneo: si trattava di un vero e proprio regno del mare, al quale in un primo momento aggiunsero la Sicilia.
Un secolo dopo però l’ultima sovrana angioina, la regina Giovanna, rimase priva di discendenti e nominò suo erede proprio Alfonso d’Aragona, il quale riunificò i regni di Napoli e Sicilia sotto la sua corona. Melfi passò così nelle mani di un nuovo feudatario: Ser Gianni Caracciolo, un napoletano amante della regina Giovanna.
Inizialmente fedeli ai nuovi dominatori, i Caracciolo caddero in disgrazia presso gli aragonesi quando parteciparono alla cosiddetta Congiura dei Baroni del 1485. Le potenti famiglie feudali del Regno, come i Del Balzo Orsini, i Sanseverino, i Guevara e gli stessi Caracciolo possedevano ciascuna più ricchezze e terre dello stesso re Alfonso: per questo decisero di opporsi alle riforme da lui volute, che prevedevano un crescente ruolo delle comunità locali e della borghesia mercantile a scapito degli antichi privilegi, compresi quelli della Chiesa.
Perciò, in una riunione tenuta nel castello di Melfi in occasione del matrimonio di Troiano Caracciolo, organizzarono un colpo di Stato ma il re seppe reagire e fece arrestare e giustiziare i capi della rivolta, dopo averli attirati in un tranello nel Maschio Angioino di Napoli.
Intanto, con la caduta di Costantinopoli in mano ai musulmani, molti cristiani si spostarono dai Balcani verso il Sud Italia. Nella zona del Vulture affluirono numerose comunità albanesi, che a Melfi edificarono un nuovo quartiere alle spalle della Cattedrale, delimitato da quattro strade e anticamente chiamato “la terra nova”, poi Chiùcchiari dal nome di una delle famiglie albanesi più importanti. Il gruppo si integrò presto nella comunità melfitana, alla quale offrì nel corso del tempo importanti uomini di cultura, chierici e notai, come i vari esponenti della famiglia Bocdam.




